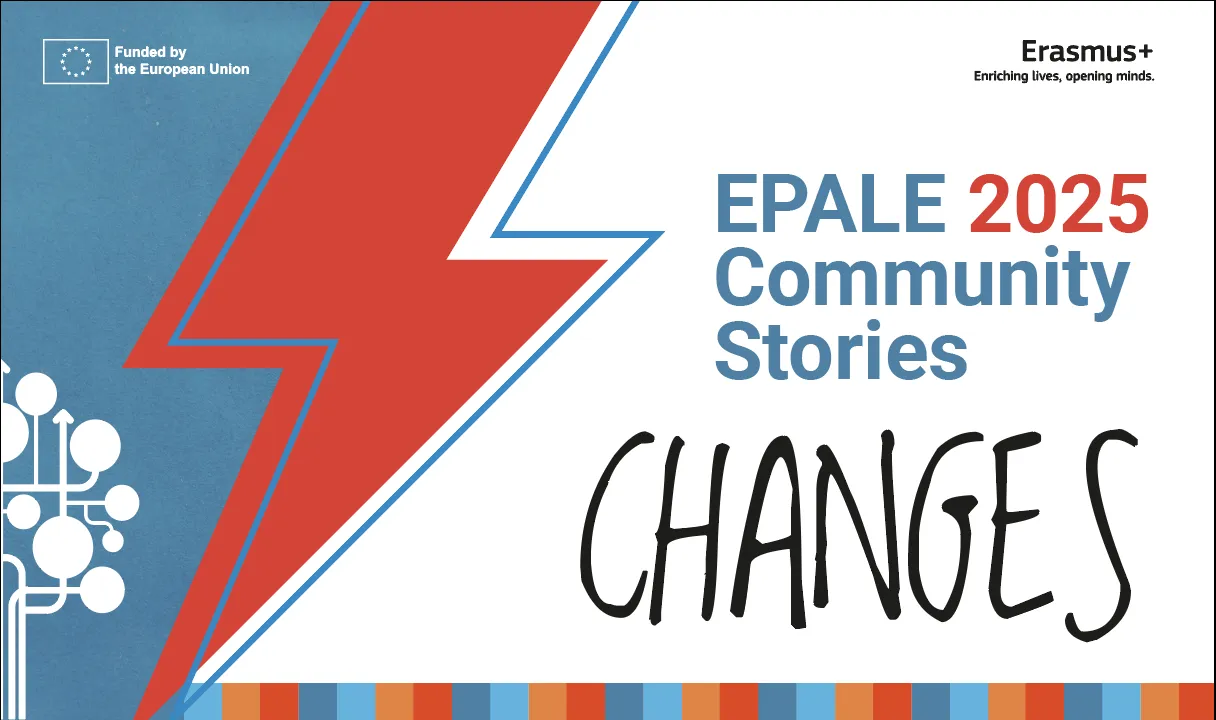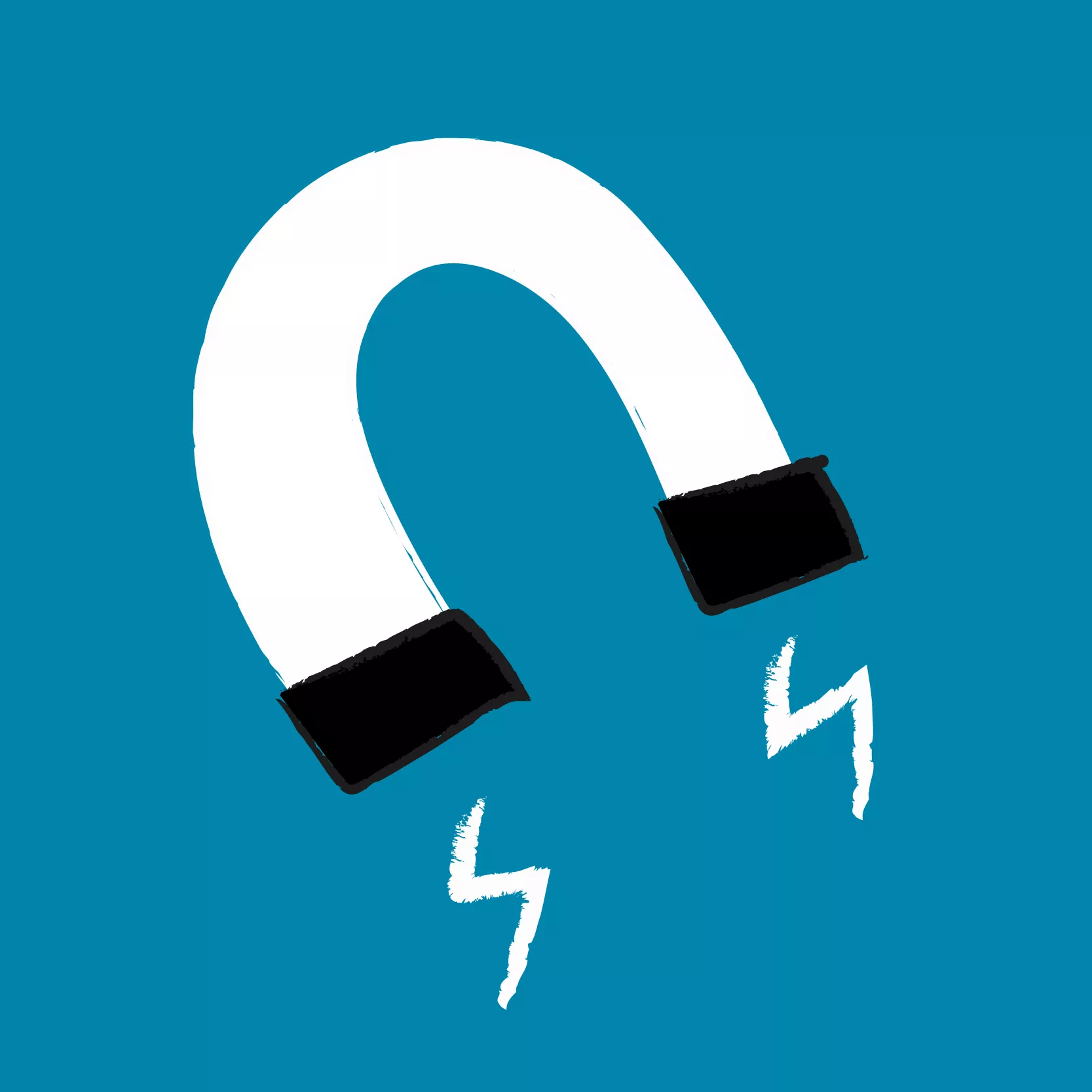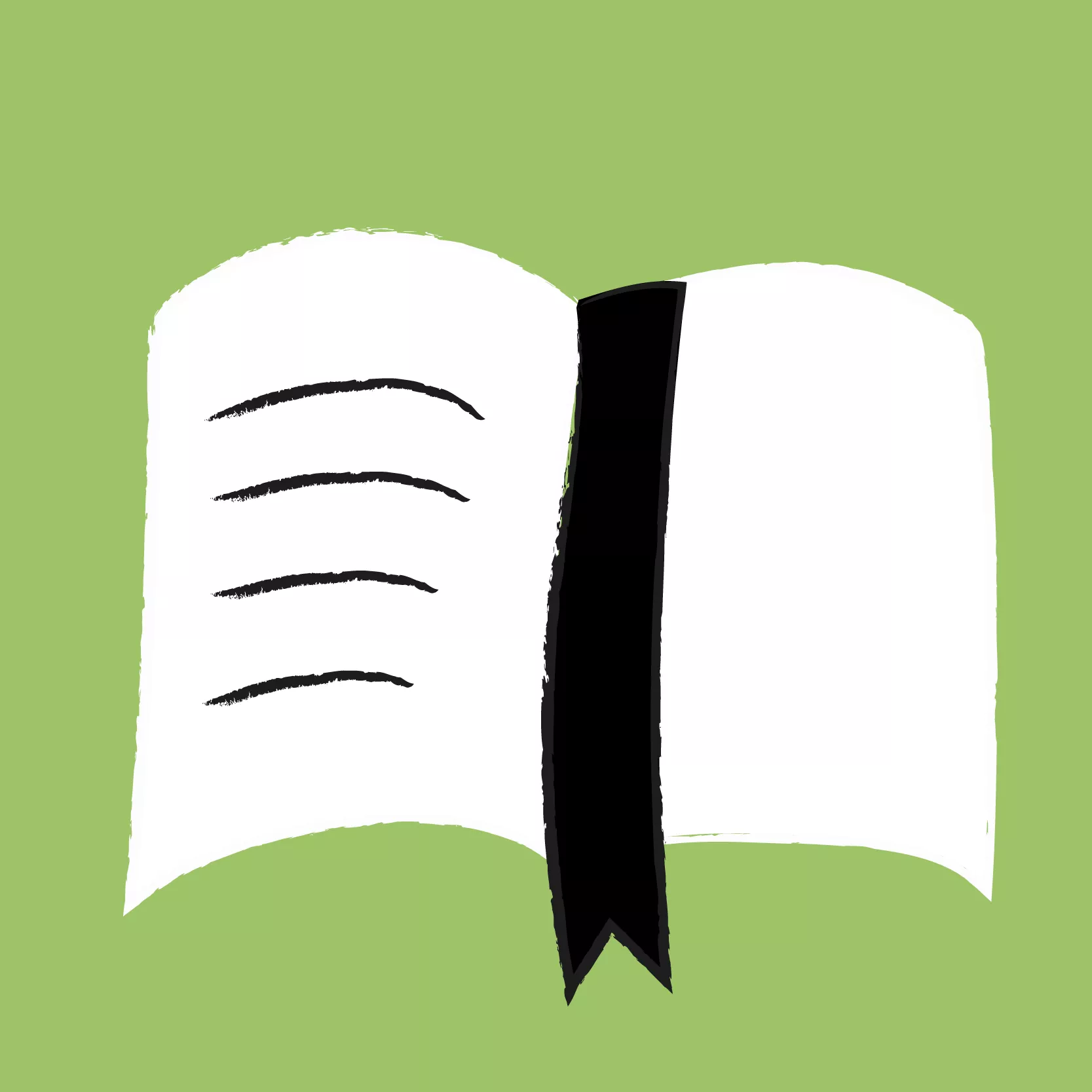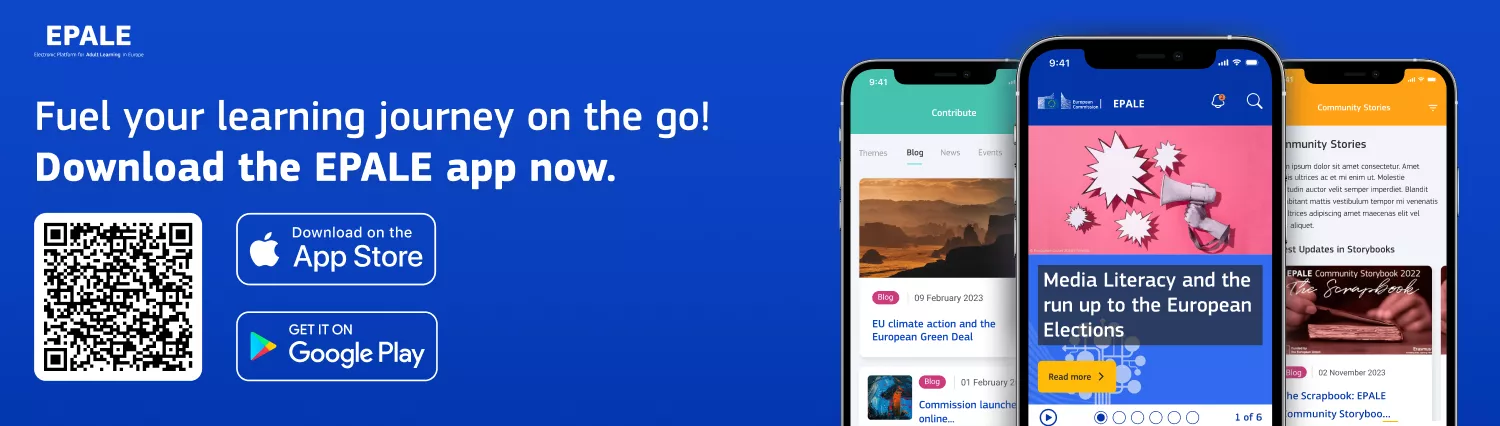Ecofarms4Prisons: al via il corso per educatori di adulti e personale carcerario
Ecofarms4Prisons: al via il corso per educatori di adulti e personale carcerario
Aperte le iscrizioni per la formazione online promossa dal progetto Erasmus+ Ecofarms4Prisons per educatori e personale carcerario che vogliono portare la sostenibilità, l'agricoltura sociale e l'impatto reale negli istituti penitenziari.