Il nuovo “Ordinamento Penitenziario minorile”. La fine “apparente” di una lunga attesa
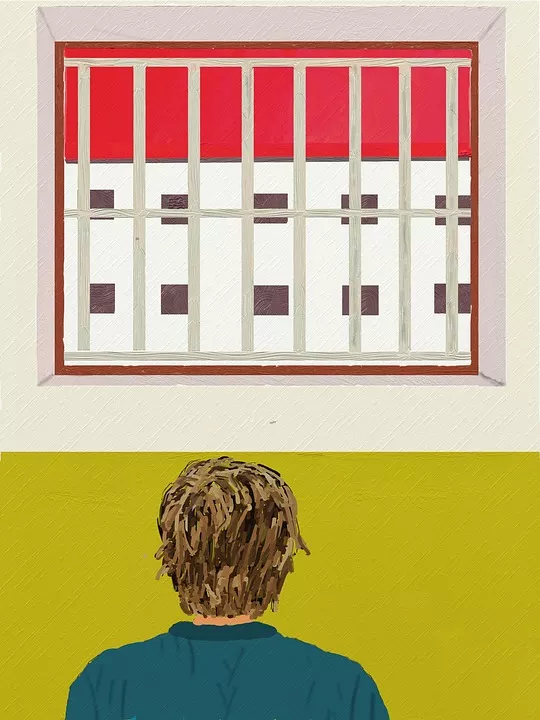
Il nuovo “Ordinamento Penitenziario minorile”. La fine “apparente” di una lunga attesa
L’approvazione del d.lgs. 2 ottobre 2018, n 121, Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, (GU Serie Generale n. 250 del 26–10–2018 – Suppl. Ordinario n. 50), e la sua entrata in vigore il 10 novembre 2018, hanno segnato apparentemente la fine di una lunga attesa protrattasi per oltre quarant’anni.
Correva l’anno 1975, infatti, allorquando la legge n. 354 del 26 luglio, istitutiva dell’Ordinamento Penitenziario sostanzialmente tuttora vigente, aveva espressamente indicato la necessità della creazione anche di un apposito ordinamento penitenziario minorile, tanto da prevedere nello specifico, all’art. 79, che: «Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».
Una lacuna, però, durata ben 43 anni, che si è cercato di colmare più volte nel corso dei quattro decenni resisi necessari, per addivenire poi ad un risultato attuale comunque parziale, poiché nulla di nuovo è stato finora detto su una pena possibilmente diversificata da applicare ai minorenni autori di reato, lasciando che il nostro sistema non possa prevedere ancora un diritto penale sostanzialmente minorile. Dunque, gli stessi comportamenti che costituiscono reato per gli adulti lo costituiscono anche per gli infra–diciottenni e identiche sono pure le sanzioni (con l’eccezione significativa dell’ergastolo): tutte le differenze sono costituite dal sistema processuale e dell’esecuzione penale.
D’altronde, si è sempre immaginato che lo sforzo di liberare il sistema del trattamento dei minori autori di reato dai forti legami con il modello della giustizia criminale degli adulti, sarebbe stato lungo e faticoso, costantemente viziato o inficiato dal tentativo di adattare ai minori approcci logico–giuridici, però, nati e sviluppati per il trattamento dei soggetti adulti maggiori di età.
Quello che ormai è già ribattezzato come Ordinamento Penitenziario minorile,[1] , la cui promulgazione è avvenuta quasi in sordina per i non addetti ai lavori, e che ha colto invece quasi in contropiede gli stessi operatori socio-educativi di area penale interna ed esterna dei Servizi Minorili della Giustizia (di fatto non consultati dalle alte sfere politiche nel processo di “decision making” legislativo, peraltro alquanto travagliato fin dalle prime battute di avvio della cosiddetta “riforma Orlando” un paio di anni prima), va a disciplinare nel dettaglio:
- l’implementazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, casi particolari di affidamento in prova), significativamente ridenominate “misure penali di comunità”, rivisitate accentuando lo scopo di favorire l’evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero (capo II);
- le condizioni di estensione delle norme previste dall’Ordinamento Penitenziario minorile anche ai giovani adulti (art. 9 e 10), di età ricompresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), comunque autori di reato commessi nel corso dell’età imputabile (da 14 anni ai 18 anni non compiuti);
- la necessità di un progetto educativo personalizzato dal carattere non meramente formale, previo ascolto del condannato (art. 14);
- l’esigenza di separazione, nell’assegnazione dei detenuti, dei minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati (art. 15);
- la necessità che le camere di pernottamento negli Istituti Penali per Minorenni (IPM) non ospitino più di quattro persone (art. 16);
- la permanenza dei detenuti “all’aria” (ossia al passeggio in cortile) per almeno quattro ore al giorno (art. 17);
- il diritto del detenuto a effettuare otto colloqui visivi mensili e da due a tre colloqui telefonici della durata di venti minuti ciascuno con i propri familiari (art. 19), ampliando i precedenti limite rispettivamente di 6 ore mensili di colloqui visivi e di 1 solo colloquio telefonico settimanale della durata di dieci minuti;
- la possibilità di consentire visite prolungate, fino a quattro ore al mese, con i congiunti o con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di una durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei ore, da svolgersi in unità abitative di cui gli IPM dovranno appositamente essere attrezzati internamente;
- la rafforzata tutela del principio di territorialità dell’esecuzione, ossia che la pena debba essere eseguita in Istituti quanto più alla residenza o all’abituale dimora dei detenuti e delle loro famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio–familiari educativamente e socialmente significative (art.22);
- la composizione del Consiglio di Disciplina per le sanzioni più gravi (art. 23), col Giudice Onorario minorile che prende il posto del Sanitario d’Istituto nella triade del gruppo che compone il Consiglio, a cui prendono parte (e prendevano già parte originariamente) il Direttore dell’IPM e un educatore penitenziario minorile (Funzionario di Professionalità Pedagogica);
- la puntuale cura e preparazione delle dimissioni dei giovani detenuti dagli Istituti Penali Minorili onde evitare discontinuità tra il progetto educativo e di reinserimento predisposto prima delle dimissioni e il programma di formazione e sostegno in area penale esterna (art. 24).
Per opportuni approfondimenti si rimanda ai seguenti link:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN106518&previsiousPage=mg_1_2
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/26/18G00147/sg
Marco Brancucci
Ambasciatore Nazionale EPALE – Regione Puglia
PhD “Scienze delle relazioni umane” – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Funzionario di Professionalità Pedagogica – Istituto Penale per Minorenni di Bari “Nicola Fornelli”
[1] Questo decreto fa parte di un pacchetto di quattro dispositivi di legge, gli unici finora approvati, che solo parzialmente realizza il più ampio progetto riformista avviato nel corso della XVII legislatura. Gli altri decreti adottati sono i seguenti: Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103; Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103; Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. I quattro decreti menzionati sono stati tutti pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50, e sono entrati in vigore simultaneamente il 10 novembre 2018.




