Il medium è il messaggio? Sì, anche per gli adulti! Ovvero, la media education nella formazione degli adulti

“I media non sono più uno schermo che si guarda, una radio che si ascolta. Sono un’atmosfera, un ambiente nel quale si è immersi, che ci avvolge e ci penetra da ogni lato. I media sono un nuovo modo di essere vivi”.
Carlo Maria Martini
Cominciamo dalla conclusione: aveva ragione Marshall McLuhan, quando con spirito profetico, coniò la sua celebre sintetica espressione "il medium è il messaggio". L’idea si applica, senza eccezioni, anche al mondo dell’educazione degli adulti.
A conferma di ciò, la parola autorevole di Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica, Tecnologie dell’Istruzione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano, fondatore e direttore del Centro di Ricerca per l'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia (CREMIT). Egli conferma che il sociologo canadese riteneva, infatti, che ogni medium va esaminato per i criteri strutturali in base ai quali organizza la comunicazione, questo perchè la sua particolare struttura lo rende non neutrale agli utenti-spettatori, ma portatore di una certa “forma mentis”.
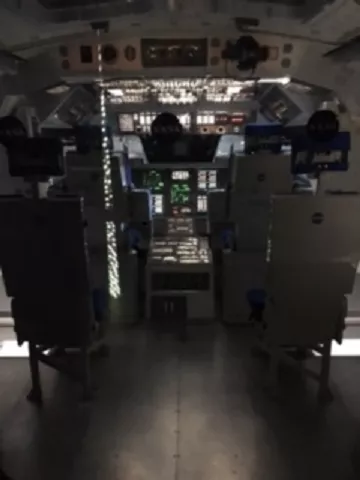
Di qui la necessità di disporre di una disciplina che si collochi all’incrocio, tra le Scienze della Formazione, e i “saperi” della comunicazione, quali la Linguistica, l’Informatica e il Diritto. Quello che indicano Educazione e l’Alfabetizzazione Mediale, appunto. Nell’intervista rilasciata per Epale, Rivoltella ripercorre origini e funzioni della Media Education in oggetto.
- Quale ruolo/funzione riveste la Media Education nel panorama della formazione degli adulti?
L’educazione ai media è una prospettiva relativamente nuova, nei piani pedagogici degli educatori, che si rivela, però, ogni giorno più attuale per garantire individui pienamente consapevoli della complessità del presente e responsabilizzati riguardo ai propri diritti civici
Nasce e viene pensata in un contesto scolastico, in prima battuta, sulla scorta dello sviluppo incrementale delle nuove tecnologie e al loro ingresso pervasivo e totalizzante nella vita quotidiana e nelle pratiche educative. Una rappresentazione dell’infanzia come età fragile, non protetta e vulnerabile unita ad una presupposizione dell’adolescente come capitale umano inferiore a quello dell’adulto, incapace di difendersi, hanno completato il paradigma iniziale.
A livello internazionale, soprattutto in Nord Europa, si è avvertita poi l’esigenza di includere le fasce anziane della popolazione: nella società dell’informazione, che tende a digitalizzare sempre più i servizi, individui non alfabetizzati mediaticamente corrono il rischio di non vedersi riconosciuti i propri diritti di cittadinanza.
In aggiunta il coinvolgimento delle figure parentali per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e stalking è seguito alla diffusione massiccia dei mezzi di comunicazione di massa negli ambienti familiari e lavorativi: i media non sono più qualcosa di circoscrivibile ma sono diventati una dimensione naturale in tutti i contesti, anche professionali; questo ha fatto emergere nuove problematiche giuridiche e ha portato a esplorare maggior conoscenza sull’impatto, ad esempio, dei social network sulle prestazioni lavorative; così sempre più di frequente ci si interroga sull’opportunità di consentire l’accesso ai media in orario d’ufficio, mentre numerose aziende ne vietano l’uso.
2. Si può dire che Media Education costituisca una tematica trasversale ai diversi approcci disciplinari nell'ambito del settore adulti?
Sì, infatti essere alfabetizzati strumentalmente è altro dall’essere “media educati”, cioè consapevoli della rilevanza dei media, a qualsiasi età. Nel libro intitolato “Media Education” (2001, Carocci Editore) definivo che cosa è Media Education: un campo di studi interdisciplinare che si delinea tra le scienze della comunicazione e le scienze della formazione: la sociologia dei media e l’analisi dei consumi per ricomprendere anche la semiotica, l’analisi dei testi, la didattica e, infine, le metodologie di didattica e animazione.
Possiamo dire che, negli ultimi anni, assistiamo a un’esplosione della tematica mediale al di fuori dei contesti scolastici e a un ingresso sempre più significativo nell’educazione degli adulti, in una prospettiva sempre più lifelong-learning-oriented. Ogni nuova tecnologia esercita su chi ne fruisce un effetto molto potente: se si dispone degli anticorpi intellettuali si riesce ad evitare di esserne fagocitati e a distinguerne gli assiomi sottostanti e le linee di forza. In altre parole, un approccio consapevole all’utilizzo dei media permette non soltanto l’esercizio critico ma anche la maggiore capacità di comprendere la realtà ed i mutamenti sociali, prerogative tipiche della maturità.
3. Quali sono i compiti della Media Education e quali obiettivi può raggiungere, a partire dalla considerazione di fenomeni come il digital divide, la trasformazione digitale, la mancanza di competenze e le consapevolezze nell'utilizzo degli strumenti multimediali?
Il divario digitale e tutti gli aspetti problematici relativi all’utenza non possono dirsi superati se non si raggiunge, in primis, la connessione fisica con la rete.
Il superamento del divario digitale non è questione limitabile nè geograficamente nè temporalmente: si estende dalla Cina, il gigante asiatico, passando per il continente africano fino al Medio Oriente con un particolare riferimento alla condizione di subalternità femminile in molti paesi arabi e non solo.
Tuttavia la disparità non è solo relativa all’accesso, ma è soprattutto riferita agli alfabeti culturali di cui molti non posseggono le chiavi di interpretazione concettuale.
La pedagogia degli oppressi, di Paulo Freire, ricorda la necessità di mettere a punto politiche mirate nei paesi in via di sviluppo: la coscientizzazione dei campesinos attraverso l’insegnamento del pensiero critico per ottenere la liberazione dal potere ne costituisce un esempio, come insegna l’esperienza dello studioso sudamericano che, a partire dagli anni ‘50, durante l’esilio fino al riconoscimento UNESCO, si spenderà per l’emancipazione degli ultimi attraverso la pratica dialogica e linguistica.
All’incirca negli stessi anni, un giovane Don Milani si adoperava in Italia per migliorare la condizione dei meno abbienti che pagavano l’arretratezza materiale e culturale del Paese con la conseguente impossibilità di vedere rispettati i propri diritti. La celebre sentenza del Priore “La parola fa eguali” indica come l’alfabetizzazione rappresenti un elemento imprescindibile di crescita e mobilità sociale.
In un mondo in continua evoluzione urge perseguire lo sviluppo del pensiero critico e la responsabilità personale, secondo gli obiettivi più tradizionali della Media Education, con un apprendimento lungo tutto l’arco della vita: se un utente sa leggere il messaggio in modo critico, senza farsi condizionare dall''influenza del mezzo, non ne rimane vittima. Al tempo dei media mainstream la comunicazione aveva un flusso one-to-one e il contenuto era canalizzato in modo definito; nella Mediapolis odierna, con la molteplicità mediale esistente, come notava Roger Silverstone, la maggior parte degli scambi avviene secondo una dinamica many-to-many in cui tutti siamo fruitori e produttori di contenuti, allo stesso tempo. Di qui deriva la categoria della responsabilità riferita alla disponibilità di individui adulti consapevoli, perciò formati, critici e padroni del proprio pensare ed agire.

4. La Commissione europea e le altre istituzioni sono intervenute negli ultimi anni (gruppi di esperti, conferenze, campagne di comunicazione) per sensibilizzare ad un uso consapevole dei media. Si può fare di più? Che cosa manca? Quali i prossimi passi a livello di politiche pubbliche?
Oltre a valutare gli indirizzi delle policy messe in campo per affrontare la digital transformation la Commissione Europea, con le altre istituzioni comunitarie, produce norme e dà supporto agli stati membri per arginare le problematiche emergenti. Sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza e facilità d'accesso ai finanziamenti per la ricerca così da redistribuire le risorse in modo più diffuso a tutti i possibili beneficiari, compresi enti ed istituti non appartenenti ai network lobbistici internazionali.
5. Vi sono esperienze di successo e buone prassi a livello nazionale, internazionale? A che punto siamo in Italia?
Negli ultimi anni, in Nord Europa, si sono registrati studi interessanti, ad esempio da parte della Lapland University, in Finlandia, che hanno reso soggetto di ricerca la popolazione anziana. Anche indagini condotte in Italia hanno portato a risultati confortanti sul costrutto di "tecnologia di comunità": costrutto sperimentato come protocollo di intervento che, adottando tecnologie solitamente percepite come disgregatrici, agisce all’opposto per creare legami a partire dalla situazione di vita del soggetto (es. la dimora dell'anziano). Si riscontrano anche esperienze interessanti in Sud America che puntano all'attivazione della promozione sociale e culturale nei quartieri più poveri.
6. Come si diventa esperti di media education? Quali i percorsi formativi?
Per conseguire una specializzazione professionalizzante i percorsi sono molteplici: si può partire da studi pedagogici oppure immettersi da un curricolo in Scienze della Comunicazione. Solitamente la provenienza da una formazione nell'area della comunicazione, piuttosto che pedagogica, facilita perché le discipline del linguaggio sono complesse. Attualmente in Italia, presso l'Università Cattolica di Milano, è attiva la Laurea Magistrale in Media Education, erogata in modalità blended, che consente lo studio delle discipline della formazione immergendosi nelle grandi questioni del rapporto tra educazione e media. Sempre alla Cattolica, la sede di Brescia propone il master accademico di II livello, unico nel suo genere, che si intitola Media Education Manager (MEM): il fine è affinare profili professionali in grado di utilizzare i media digitali e sociali, dal computer agli smartphone, per coordinare e gestire i processi di apprendimento degli adulti con lo sviluppodi conoscenze e competenze nell'ambito aziendale e della consulenza
7. Per concludere, una battuta sulla celebre tesi di Mc Luhan riportata nell’incipit?
Dalla comparsa dei media l'aspetto più interessante sembra essere proprio il tipo di dispositivo di cui ci si avvale. Questa progressiva centratura, declinata non solo in termini strumentali ma anche culturali, sarà tanto più valida nel settore degli adulti quanto più si punterà ad edificare una società di individui capaci di governare la complessità dell’oggi e l’incertezza del domani.
Commento
concordo sulla necessità
- Accedi o registrati per poter commentare





Una visione organica?