What is ‘literacy’?
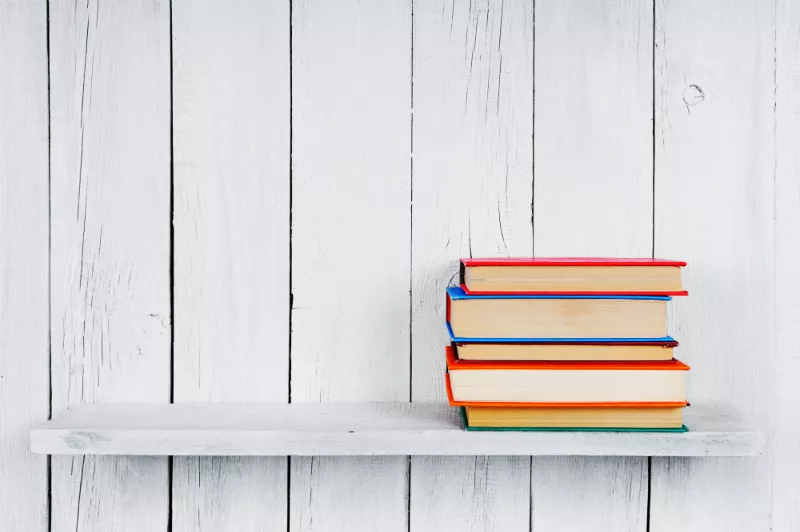
The first question that we will address in EPALE’s September discussion on adult literacy is what we actually mean when we talk about literacy. The English word ‘literacy’ has a simple definition – the ability to read and write – and yet its precise meaning is subject to endless debate, not least in European projects, as literacy does not have a direct translation in many languages.
Reading and writing
Reading and writing are foundation skills. Not only are they required for further study, they are also crucial in helping us to understand and engage with the world around us. In this sense literacy is highly contextual – what we are required to do with our literacy is always contextualised – situated within a particular socio-cultural setting. Indeed, it has become common to refer to literacies, rather than literacy, to emphasise the point that literacy is a social practice and so there is not one form of literacy that everyone needs. Instead, we all need (and use) different literacies depending on our social or professional group (e.g. nurses, teenagers, academics); the kinds of activities we engage in (e.g. shopping, dealing with bureaucracy, studying etc. ); and the different social and institutional contexts in which we act (school, work, home etc.).
In many cases literacy is given a broader definition – often including speaking (as in the English Adult Literacy Core Curriculum), but sometimes also soft skills such as team working and learning to learn. There is also the expression ‘basic skills’, which is often used interchangeably with literacy. However, basic skills (as the plural suggests) is an umbrella term – encompassing numeracy and digital skills as well as reading and writing.
Other literacies
A further complication for translators is that 'literacy' has another meaning in English. As well as being used to talk about the ability to read and write, it is common for literacy to be preceded by a term referring to a specialised field. Thus, we have computer literacy, financial literacy, quantitative literacy, emotional literacy, and many others (I've just found 33 of them including ocean literacy). While for each of these specialised areas the use of information mediated by text, often specialised text, plays an important role, the meaning of literacy here is not reading and writing, but competency – being able to engage competently in that area.
Illiteracy and functional illiteracy
When considering what literacy is, we also need to distinguish between illiteracy (not being able to read and write at all), and functional illiteracy (being able to read and write, but not well enough to meet the demands of everyday life). An adult can only be deemed functionally illiterate if they cannot meet the demands placed on them in their own particular social and professional context. Of course, the demands placed on adults change continually – just because someone was once functionally literate does not mean that they will be able to adapt to new and different demands and remain functionally literate.
Finally, we should be very careful about our use of the term ‘illiterate’. There are very few adults in Europe who are illiterate, particularly in younger generations, largely due to the introduction of universal schooling. There are large numbers of people in every European country who are unable to meet the demands on them in terms of reading and writing, or who are limited in their life choices by their poor literacy skills, but they can read and write. They are not illiterate, they are functionally illiterate.
David Mallows has 30 years of experience in adult education as a teacher, teacher trainer, manager and researcher. He was previously Director of Research at the National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy (NRDC) at the UCL Institute of Education, London and currently represents the European Basic Skills Network in EPALE as thematic coordinator for Life Skills.
Comments
Niedoceniane pisanie
Pisanie, przynajmniej w nauczaniu języków obcych często uchodzi za sprawność najmniej potrzebną i zatem rzadko ćwiczoną na zajęciach. W rzeczywistości zawodowej okazuje się jednak, że pisanie, zwłaszca w dużych korporacjach ma coraz większe znaczenie. Szereg dokumentów przygotowywanych jest w formie pisemnej, co więcej firmy coraz częściej skłonne są zapłacić za szkolenia pracowników w zakresie efektywnego pisania. Pisanie jest także coraz częściej sprawdzane wśród kandydatów starających się o pracę. Chcę podkreślić, że komunikacja pisemna już dziś jest wymaganiem, a wkrótce będzie koniecznością na rynku pracy.
L'insegnamento della letteratura italiana
Insegno da molti anni Lingua e letteratura italiana al triennio di un ex corso serale e all’inizio di ogni anno scolastico propongo alle mie classe una riflessione sulla letteratura. Cosa serve la letteratura per gli adulti?
Il mio discorso parte dalla pagina introduttiva delle Lezioni americane di Italo Calvino: «La mia fiducia nella letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici»[1]. Qualche anno prima lo stesso Calvino aveva scritto: «I classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale. [...] I classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia delle letture che hanno preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che hanno lasciato nella cultura o nelle culture che hanno attraversato (o più semplicemente nel linguaggio e nel costume). [...] D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. [...] I classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili per confrontarli agli italiani»[2].
Concetti facili per chi come me è sempre stata pronta a leggere i classici. Tuttavia, come far capire ciò ad un studente adulto che ha lasciato la scuola da molto tempo e che non ha mai avuto modo di confrontarsi con un classico? Come rispondere alle domande di questi studenti adulti che, a volte anche tristi e delusi dalla vita, ti dicono che non hanno tempo di leggere niente, che quando leggono si annoiano e che sono diffidenti sul valore della letteratura?
Mi armo di tanto coraggio e imposto la mia didattica consapevole che insegnare la letteratura italiana sui classici significa aprirsi nei confronti di quella che Erich Auerbach, nel 1952, definì la Weltliteratur[3]; in questo modo, “butto” letteralmente i miei alunni sui testi letterari, al fine di prepararli non sul piano scolastico, ma per stuzzicarli, visto che hanno già alle spalle un’esperienza personale di formazione umana e professionale, sul piano civile, anzitutto etico e di conseguenza politico. Quindi, attraverso lo studio della letteratura e dell'arte, invito i miei alunni ad approfondire quello che ancora Auerbach definì «lo studio della realtà del mondo»[4].
Considerate queste premesse, presento la letteratura e i suoi testi, facendo emergere la percezione critica dell'alterità del nostro passato, della sua irriducibile differenza, per conservare la memoria storica di una communitas, di un bene comune che è insieme lingua, tradizione culturale, universo letterario e artistico. «Scommettere sui classici», scrive Luca Serianni, «significa pensare che abbiano ancora qualcosa da dirci; e che ce lo dicano, finché è ancora possibile comprenderla, nella lingua in cui sono stati scritti, ossia con la loro voce»[5].
Ai miei alunni insegno che la letteratura va colta nella sua natura più profonda, come «funzione esistenziale», come «ricerca di conoscenza» (sono ancora le Lezioni americane)[6].
Tuttavia, fin dal primo giorno di scuola, sono onesta con questi alunni che hanno abbandonato da tempo i banchi di scuola.
Spiego loro, come afferma il prof. Corrado Bologna, che la letteratura, certo, non riesce mai a rispondere a quell’esigenza radicale che Carlo Emilio Gadda definiva come urgenza di «mettere in ordine il mondo»[7]. Non metterà mai veramente “in ordine” il mondo, non riuscirà mai a realizzare un paese migliore. Confesso loro con le parole del prof. Bologna che «la letteratura si offre, invece, quale perfetto dispositivo di accoglienza, entro un sistema coerente di significato, dell'infinita molteplicità di dettagli irrilevanti che si disseminano nella “liquida” vita quotidiana. Essa riesce a dare parola al bisogno di ordine nella visione della realtà proprio portando alla luce la grande disarmonia che vi domina, offrendo una voce consistente, coerente, all’incoerenza e al caos della vita, mostrando come cose infinitamente diverse possono convivere ed entrare in contatto senza mai rinunciare alla propria specificità, nella complessità del sistema»[8].
In questa prospettiva, insegnare ad amare la letteratura comporta necessariamente che ci sono cose che non si “imparano”, che ci sono “competenze” rispetto alle quali saremo sempre “incompetenti”, perché non si “acquistano”, non si “comprano”, ma si gustano, si vedono, si ascoltano, si fiutano, si assaporano. Come ancora afferma Bologna: «la letteratura fa sì che due più due dia cinque, un passo più a nord del confine della realtà che impone il quattro; essa esercita ad attraversare confini, offrendo al lettore la forza per riportare nello spazio dell'identità, individuale o collettiva, il progetto utopico ma non irrealizzabile di un futuro diverso»[9].
Spiego, inoltre, che insegnare letteratura non può voler dire addestrare principalmente a leggere la lingua dei classici per imparare a riprodurla. Insegnare letteratura, ragionando sui testi dei grandi classici, significa “far venir fuori” (è questa l’idea dell’educare) dagli allievi, e ancor più dagli allievi adulti, un'avvertita capacità di elaborazione intorno ai procedimenti logico-argomentativi del pensiero umano nella sua forma più alta e limpida. «Significa esercitare a sentire nella pagina del grande classico la perturbante originalità di un punto di vista che guarda alle radici dell'esistenza, a riconoscervi la forza innovativa che il classico conserva e può ancora trasmettere grazie alla “radicalità”, appunto, della sua visione del mondo rivoluzionaria. Significa plasmare una consapevolezza della necessità, ma al contempo della parzialità, di ogni “competenza” tecnica, creando invece uno spirito critico, cioè una distanza interiore capace di riscattare la profondità dello sguardo, del punto di vista ermeneutico, nel senso più completo del termine. Significa far maturare nei discenti la capacità di commisurare l'infinita, imprendibile varietà delle cose e delle esperienze con l'irriducibilità dei limiti umani, far cogliere la fatica, il travaglio della lingua dei classici mentre “cerca la parola” per dire l'umanità come progetto di futuro e nel contempo come limite irriducibile. Questa fatica, questo esercizio di complessità, imprime uno slancio antigravitazionale verso una visione del mondo diversa, molteplice, innovativa, scandita nel senso della storia e del recupero delle radici di una civiltà con la leggerezza con cui Calvino apre le Lezioni americane»[10].
Nella prospettiva fin qui tratteggiata, quindi, il primo problema da affrontare è come far appassionare al testo gli alunni adulti.
L’unico mezzo possibile è unicamente passare attraverso il godimento profondo del piacere del testo, dell'avventura conoscitiva ed esistenziale dell'incontro con l'universo perturbante dei grandi classici, e solo così sono riuscita pienamente a far amare la letteratura.
Al di là di qualsiasi basilare acquisizione di competenze linguistiche e tecnico-esegetiche è sempre necessario far sentire con profondità e autenticità agli alunni adulti, per i quali il testo è lontanissimo dalla loro realtà quotidiane, la carica etica di memoria, di energia, di piacere, di stupore, che fa della letteratura un elemento fondamentale per la vita stessa dell’individuo.
Per concludere, insegnare letteratura italiana non è solo insegnare “la lingua”, né solo “la letteratura”, ma mostrare e far amare l'intera “civiltà italiana”, tutta la civiltà che dal nostro Medio Evo è ancora tangibile nelle piazze dei nostri comuni, nei nostri modi d'essere e di agire, di vivere, di pensare.
Ai miei alunni insegno con forza che la nostra civiltà, attraverso la nostra lingua, attraverso la nostra letteratura, deve continuare ad essere orizzonte e bussola, consolazione e riscatto dell'umano, di fronte a chi «cerca di ridurci a bestie», se non portandoci alla morte fisica, di certo soffocando lo spirito di comunità, la democrazia, la condivisione dei progetti e dei sogni, cioè del futuro. E se «noi bestie non dobbiamo diventare», «per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà»[11].
[1] I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988, p. 1; poi in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Berenghi, 2 tomi, Milano, Mondadori, 1995, p. 629.
[2] Id., Perché leggere i classici (1981), in Id., Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1991, pp. 11-19 (alle pp. 13- 14, 15 e 19), poi in Id., Saggi 1945-1985 cit., pp. 1816-1824 (alle pp. 1818-1819, 1824).
[3] Cfr. E. Auerbach, Philologie der Weltliteratur (1952), in Id., Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Francke, Bern 1967, pp. 301-310; trad. it. Philologie der Weltliteratur - Filologia della letteratura mondiale, Book editore, Castel Maggiore (Bologna) 2006 (con il testo tedesco a fronte).
[4] E. Auerbach, Philologie der Weltliteratur. Filologia della letteratura mondiale cit., p. 37 (la formula originale è: «Erforschung der Weltwirklichkeit»).
[5] L. Serianni, L'ora di italiano. Scuola e materie umanistiche, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 106.
[6] I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 28; in Saggi 1945-1985, cit., p. 653 (da qui anche la frase virgolettata che segue).
[7] C. E. Gadda, Meditazione milanese, a cura di G. C. Roscioni, Torino, Einaudi, 1974, p. 172, I stesura, cap. XIII, La categoria, rr. 157-158; poi in Id., Scritti vari e postumi, a cura di A. Silvestri, C. Vela, D. Isella, P. Italia, G. Pinotti (“Opere di Carlo Emilio Gadda” ed. diretta da D. Isella), V*, Milano, Garzanti 1993, p. 735.
[8] Corrado Bologna, La letteratura come visione del mondo (Napoli, 25-27 ottobre, Convegno sul tema: Insegnare Lingua e Letteratura italiana nei nuovi Licei e Istituti superiori).
[9] IDEM
[10] IDEM
[11] P. Levi, Se questo è un uomo (1958), in Id., Opere complete, a cura di M. Belpoliti, con Introduzione di D. Del Giudice, 2 voll., Torino, Einaudi, 1997, I, p. 35.
ANALFABETISMO CULTURALE
Condivido pienamente queste considerazioni.
Lavoro da molti anni in corsi serali di istituti tecnici e professionali e mi accorgo ogni anno che l'analfabetismo è più di tipo culturale: riguarda la storia, l'educazione civica, la geografia, il diritto.
La lettura è inespressiva e la scrittura è incerta, perché manca una base culturale, troppo spesso superficiale.
E' importante considerare l'apprendimento come una formazione completa per lo sviluppo della persona.
Pracując z osobami starszymi
Pracując z osobami starszymi często spotykam się z problemem zrozumienia szczególnie informacji urzędowych, prawnych czy nawet prostych komunikatóew. Nie znaczy to, że osoby te nie potrafia czytać - doskonale dają sobie radę z literaturą piękną, potrafią ze szczegółami opowiedzieć treść powieści czy opowiadania. Jednak gdy z krótkiego, bardzo konkretnego tekstu muszą wyłowić szczegóły to pierwsze czytanie jest zwykle mało efektywne - wymaga to skupienia i czasem wielokrotnego powtarzania czytanego tekstu. Czytanie ze zrozumieniem to czasem prpblem (nie tylko chyba seniorów)





Lasītprasme un rakstītprasme
Kā blogā iepriekš rakstīts par to, ka angļu valodā vārdu "lasītprasme" piemēro definīciju - spēja lasīt un rakstīt. No vienas puses es tam varētu piekrist, jo lai trenētu savu lasītprasmi, tas nenozīmē, ka tu lasi tikai no grāmatas, interneta utt., bet arī lasi, ko pats esi uzrakstījis, un lai to izlasītu un saprastu, tad tam ir jābūt uzrakstītam skaidri. Taču no otras puses es tam nevaru piekrist, jo manā iztēlē "lasītprasme" un "rakstītprasme" ir divas dažādas lietas. Ar "lasītprasmi" es saprotu, ka cilvēks spēj paskaidrot, ko ir izlasījis, izprot tekstu utt., bet ar "rakstītprasmi" es saprotu, ka šādā veidā cilvēks trenē savu rokrakstu, lai tas būtu skaits un saprotams, tāpat arī varētu papildināt ar to, ka trenēt savu vārdu krājumu, piemēram, pārrakstot tekstus. Uzskatu, ka "lasītprasme" ir viena no galvenajām lietām, kas cilvēkam ir jāiemācās - jo tas ne tikai noderēs latviešu valodas stundās, bet arī matemātikā, fizikā, bioloģija un arī visā dzīvē. Saprast un uztvert, ko es esmu tikko izlasījis.